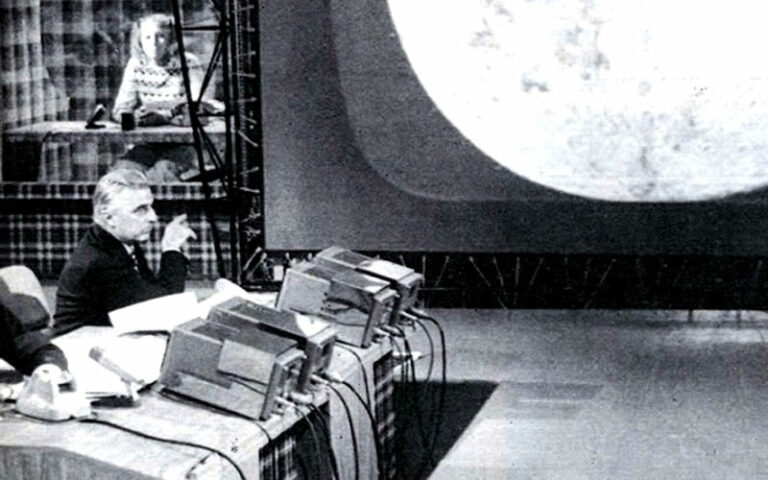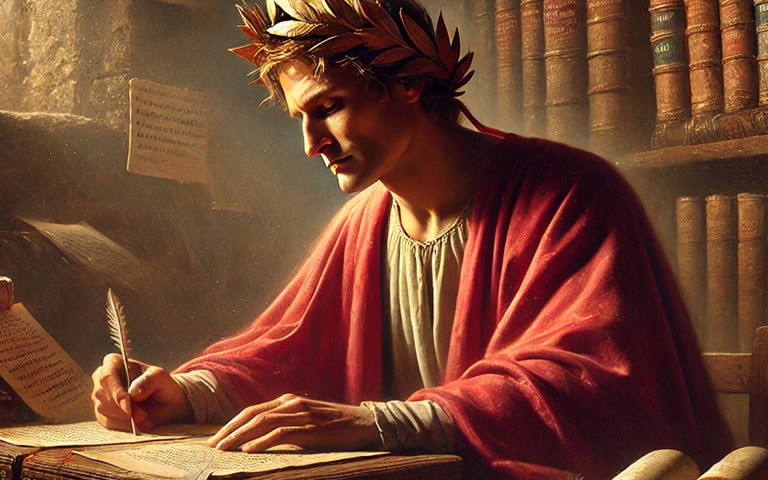Le donne nel secolo della scienza
Nel “secolo della scienza”, che si sviluppa tra il XVII e il XVIII secolo, l’Europa assistette a una vera e propria rivoluzione nelle scienze, nella filosofia e nella matematica, con un’incredibile fioritura delle conoscenze e delle scoperte. Tuttavia, questo periodo, pur essendo caratterizzato da una straordinaria apertura mentale nelle scienze, si scontrò con le rigidità sociali e culturali del tempo, che relegavano le donne in ruoli domestici e limitavano fortemente il loro accesso all’istruzione superiore. Le università e i principali centri di ricerca erano considerati territori esclusivi degli uomini, e le donne che osavano avventurarsi oltre questi confini dovevano affrontare pregiudizi e ostacoli enormi.
Tuttavia, alcune donne coraggiose, con una determinazione e una passione straordinaria, riuscirono a infrangere questi limiti e ad accedere a livelli di istruzione e competenza che sembravano inaccessibili per il loro genere. Le prime laureate, infatti, furono soprattutto italiane, che, in un periodo storico segnato dalla lentezza delle trasformazioni sociali, fecero da apripista per le future generazioni di donne scienziate.
Tra queste pionieristiche figure, quattro donne italiane si distinsero in particolare: Elena Lucrezia Corner Piscopia, Laura Bassi Verati, Cristina Roccati e Maria Pellegrina Amoretti.
Elena Lucrezia Corner Piscopia (1647-1684) è riconosciuta come una delle prime donne in Italia a conseguire una Laurea in Filosofia all’Università di Padova. Elena non solo si laureò, ma divenne anche una figura molto importante nell’ambito della filosofia, della matematica e della teologia, un mondo tradizionalmente dominato dagli uomini. La sua preparazione e il suo ingegno la portarono a entrare in contatto con alcuni dei principali pensatori dell’epoca, riuscendo a dimostrare che le donne possedevano pari capacità intellettuali rispetto agli uomini.
Laura Bassi Veratti (1711-1778) Nel 1732, all’età di 21 anni, conseguì la laurea in Fisica, divenendo la prima donna in Italia a ottenere il ruolo da prima docente universitaria. Laura Bassi non solo fu una delle prime a insegnare fisica all’Università di Bologna, ma si distinse per i suoi studi sull’elettricità e la meccanica, diventando un punto di riferimento nel panorama scientifico europeo. La sua attività di ricerca, le sue pubblicazioni e il suo insegnamento la resero una figura riconosciuta nel campo delle scienze naturali, malgrado le enormi difficoltà legate al suo essere donna in un mondo scientifico dominato dagli uomini.
Cristina Roccati (1717-1793) fu un’altra figura di rilievo nel panorama scientifico dell’epoca. Roccati, che era molto vicina al pensiero di Laura Bassi, si dedicò agli studi di Fisica e Matematica. Nonostante la sua fama non fosse ampia come quella della Bassi, la sua preparazione e il suo contributo alla scienza furono apprezzati. Si laureò all’Università di Bologna e divenne una delle figure più importanti nel campo delle scienze fisiche, riuscendo a ottenere una cattedra che le consentì di insegnare e contribuire alla crescita delle conoscenze scientifiche.
Infine, Maria Pellegrina Amoretti (1750-1791), nata a Oneglia il 12 maggio 1756, morta ivi il 12 novembre 1787. Mirabilmente precoce, a dodici anni, narrano i biografi, sapeva le due lingue classiche e ragionava di metafisica in pubbliche riunioni. Fu solennemente laureata in ragion civile (giurisprudenza), come allora si diceva, a Pavia, il 25 giugno 1777. Fu pubblicata in quell’occasione una raccolta di versi italiani, latini e francesi, tra i quali sopravvive l’ode La laurea di Giuseppe Parini. Morta trentenne, Maria Pellegrina lasciò il trattato De iure dotium apud Romanos, che fu pubblicato postumo (Milano 1788).
Le storie di queste quattro donne italiane sono simboli di un cambiamento che, sebbene lento e ostacolato dalle rigidità del tempo, ha segnato un punto di svolta fondamentale nell’accesso delle donne all’istruzione superiore e alla carriera scientifica. La loro determinazione, il loro ingegno e il loro spirito di sfida contro le convenzioni sociali hanno avuto un forte impatto, e la loro figura ha rappresentato un simbolo di speranza per le future generazioni di donne che desideravano seguire la loro passione per la scienza. Sebbene abbiano dovuto lottare per farsi strada, queste pioniere hanno superato i muri della discriminazione, contribuendo alla diffusione dell’idea che le donne, come gli uomini, fossero in grado di dare un contributo significativo alla conoscenza e alla cultura.
Aurora 2°A